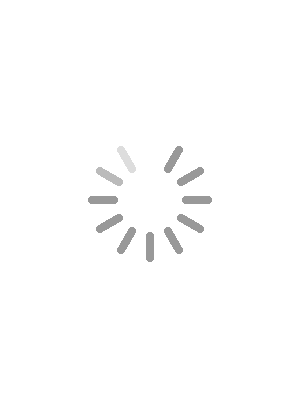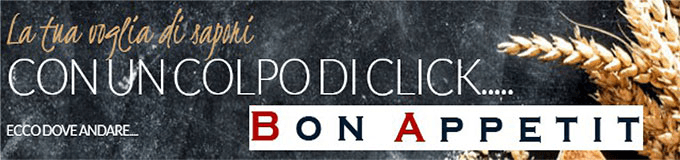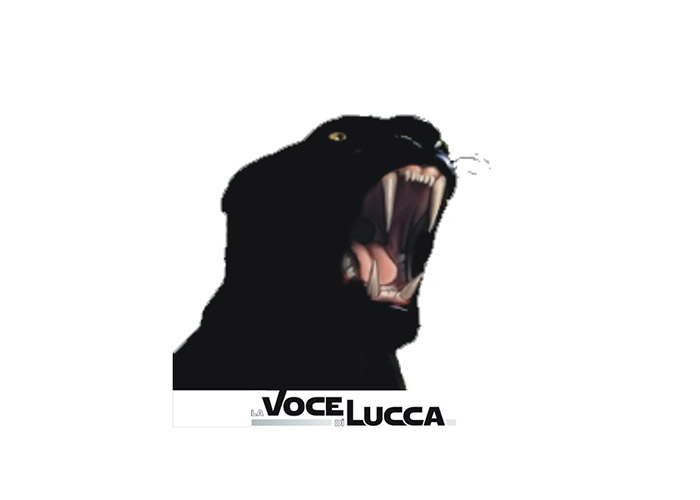Essere sani nei luoghi dei matti
????di Alessia Offredi
Essere sani nei luoghi dei matti: la delicatezza del processo diagnostico – I grandi esperimenti di psicologia
Essere sani nei luoghi dei matti: la delicatezza del processo diagnostico di D. Rosenhan (1973). Vi presentiamo una serie di articoli relativi ai più grandi esperimenti in ambito sociologico e psicologico. Per fare ciò abbiamo cercato di risalire alle fonti originarie, ai primi articoli divulgati dagli autori. In questo modo sarà più facile vivere le loro scoperte a partire dalle loro stesse ipotesi e respirare un’aria in cui, liberi (purtroppo) da vincoli etici, tutto era possibile in nome della scienza.
David Rosenhan, nato nel 1929, è stato docente di Psicologia alla Stanford University. Da sempre convinto che sia impossibile effettuare una diagnosi basandosi solo su dati obiettivi, le sue più famose ricerche sono volte proprio a confermare questa tesi. E se non ci convince, per lo meno dei dubbi li lascia.
Come potremmo distinguere, se esistono, normalità e anormalità? Negli anni ’70, Rosenhan afferma che vi sono dati conflittuali sull’utilità e sul significato di termini come ‘malattia mentale‘, ‘insanità’ o ‘schizofrenia‘. Anche oggi, ciò che viene considerato normale in una cultura può essere totalmente aberrante per un’altra. I concetti di normalità e anormalità non sono così chiari come le persone se li immaginano. Solitamente, a questo dilemma si risponde considerando se un determinato evento è o meno deviante. L’omicidio è deviante. Così come lo sono le allucinazioni. Quindi capiamo subito che questo non è un buon indice per identificare la malattia mentale.
Cambiamo quindi prospettiva e proviamo a chiederci: le caratteristiche che determinano la diagnosi sono proprie del paziente o appartengono all’ambiente in cui la persona si trova e viene valutata? Per rispondere a questa domanda, Rosenhan sceglie di verificare se un campione di persone sane (senza diagnosi attuale né in anamnesi di disturbi psichiatrici) sarebbe stato ricoverato presso ospedali psichiatrici, se si fosse scoperto il loro reale stato di salute e come. Ai finti pazienti volontari non è stato chiesto di comportarsi in modo strano, né sono stati influenzati in qualche modo dal ricercatore riguardo alla clinica in cui sarebbero stati ricoverati.
Otto persone sane chiedono di essere ricoverate in 12 differenti strutture psichiatriche. Il gruppo di volontari conta uno studente di psicologia di 20 anni, una casalinga, un pittore, tre psicologi, un pediatra, uno psichiatra. Sono tre donne e cinque uomini, usano uno pseudonimo e inventano una professione, lo staff degli ospedali ovviamente non è a conoscenza dell’esperimento. Le strutture a cui vengono inviate le domande di ricovero sono molto differenti tra loro: alcune sono statali, altre finanziate dalle università, alcune sono antiche e decadenti, altre nuove, alcune sono più orientate alla ricerca, altre no.
Dopo aver chiamato l’ospedale per fissare un appuntamento, lo pseudo-paziente si reca al colloquio preliminare al ricovero lamentando di sentire delle voci. Quando gli viene chiesto che tipo di voci siano, risponde che si tratta spesso di voci poco chiare, ma sembrano dire ‘vuoto’, ‘tonfo‘, ‘cava‘. Tali voci non sono conosciute e hanno un timbro maschile o femminile a seconda del sesso del paziente.
Tale sintomatologia viene accompagnata da un senso di insoddisfazione per la vita in generale, riferita dagli pseudopazienti: la scelta non è casuale, Rosenhan è ben consapevole che non esiste in letteratura nessuna forma di ‘psicosi esistenziale’ o patologia simile a quella descritta dai suoi collaboratori. Ai volontari è stato chiesto di rispondere alle altre domande poste in sede di colloquio secondo la loro reale esperienza, senza inventare, ingigantire o modificare nulla della loro vita. La descrizione della loro famiglia, le relazioni amicali, il percorso scolastico e lavorativo corrispondevano alla realtà.
Immediatamente dopo la loro ammissione presso le strutture coinvolte, i collaboratori di Rosenhan cessavano di riferire i sintomi descritti in sede di colloquio. In alcuni casi si sentivano moderatamente ansiosi e tesi nel primo periodo: nessuno di loro credeva che sarebbe stato ricoverato così facilmente. Tutti riferiscono dopo i primi giorni uno stato di benessere ai dipendenti della clinica, il loro comportamento è nella norma, partecipano alle attività proposte e non lamentano difficoltà. Questo è anche quello che viene annotato nei loro diari clinici. Così come accade spesso in quegli anni ai pazienti psichiatrici, a nessuno dei partecipanti vengono comunicate delle tempistiche relative al ricovero. Ad eccezione di un volontario, tutti gli altri desiderano essere dimessi nel più breve tempo possibile, ma gli viene solamente detto che verranno dimessi quando dimostreranno di essere sani.
Nessuno svelò mai la simulazione degli pseudo-pazienti. A parte uno, tutti vengono dimessi con la diagnosi di ‘schizofrenia in remissione‘. Nessun documento delle strutture coinvolte cita l’ipotesi di una simulazione da parte degli pseudo-pazienti.
Rosenhan afferma che l’etichetta ‘in remissione‘ viene probabilmente assegnata indistintamente, è una formalità, perché nell’ottica delle strutture tali pazienti non possono essere definiti ‘sani‘, né, nell’ottica delle istituzioni, lo sono mai stati. Il fallimento delle strutture nel riconoscere tale simulazione non può essere considerato dipendente né dalla qualità delle cliniche né dalla scarsità di tempo disponibile per un’adeguata valutazione: i ricoveri sono durati tra i 7 e i 52 giorni, con una media di 19.
Nemmeno il comportamento normale dei collaboratori di Rosenhan ha fatto sorgere dubbi interpretativi alle diverse equipe: tuttavia, i pazienti ospiti presso le stesse cliniche spesso riconoscevano gli attori, anche quando questi continuavano ad affermare di aver sentito voci prima del ricovero.
Messaggio pubblicitario
I dati raccolti inducono l’autore a riflettere sulla facilità da parte dei professionisti in ambito psichiatrico di incorrere nell’errore statisticamente definito ‘falso positivo‘, ovvero la tendenza a giudicare malati soggetti sani. Nello spiegare tali conclusioni allo staff di un nuovo ospedale, i dipendenti si mostrano restii a credere di incorrere veramente in tali banali errori.
Pertanto il ricercatore decide di tentare un nuovo esperimento: avvisa l’equipe che nei successivi 3 mesi avrebbero fatto richiesta di ricovero uno o più pseudo-pazienti, chiedendo di segnalargli quando avessero avuto il dubbio di trovarsi di fronte a una messinscena. Dei 193 nuovi ingressi della struttura, i membri dello staff identificano con una certa sicurezza 41 pseudo-pazienti, gli psichiatri ne individuano 23 e 19 persone vengono sospettate di essere attori sia da uno psichiatra sia da un membro diverso dello staff. Non esattamente delle ottime intuizioni, visto che Rosenhan non ha inviato presso la clinica nessun finto paziente. La conclusione non può che dare ragione al ricercatore: ogni processo diagnostico è ampiamente soggetto a errori e non può essere replicato con sicurezza da diversi valutatori.
Una diagnosi di tipo psichiatrico, afferma l’autore, porta con sé conseguenze che influenzano la vita intera. Una volta che una persona viene diagnosticata come schizofrenica, ci si aspetta che lo sia per il resto della sua vita. Quando i sintomi rimangono assenti per un periodo di tempo sufficiente, la patologia viene definita ‘in remissione‘. Ma l’etichetta rimane, così come rimangono le aspettative che, prima o poi, la persona manifesti qualche comportamento bizzarro. E queste conseguenze non si riversano solamente sul paziente, ma anche sui famigliari e sulle persone a lui vicine: non c’è da meravigliarsi se si trasformano in profezie che si auto-avverano.
A maggior ragione se si considera la tendenza all’evitamento e alla depersonalizzazione che caratterizzano, in quegli anni, le strutture che ospitano pazienti psichiatrici: i membri dello staff entrano in contatto con i pazienti solo per poco tempo durante il giorno, spesso ignorano le loro domande o evitano il contatto visivo. I livelli di privacy sono ridotti al minimo e, durante il ricovero, spesso viene applicata una sospensione dei diritti individuali. Questi elementi complicano ancora di più la possibilità di individuare, in ambienti di questo tipo, chi sta bene da chi soffre davvero. Tutti soffrono, in un modo o nell’altro.
Nelle conclusioni del suo lavoro, Rosenhan individua alcune vie d’uscita dalla situazione contemporanea. Cita l’incremento di strutture di altro tipo, comunità, centri specifici per il superamento di momenti di crisi, lo sviluppo di terapie comportamentali mirate, la tendenza a curare la persona all’interno di un ambiente che non sia di per sé fattore di peggioramento dello stato di salute. Ma non solo: l’autore nota una maggiore sensibilità da parte dei professionisti della salute mentale nei confronti delle condizioni paradossali dei pazienti psichiatrici. E forse l’ha notato proprio nel 1973, mentre con altre sette persone ha deciso di fingersi un paziente psichiatrico e ha richiesto di essere ricoverato presso un ospedale psichiatrico